Sul numero 41 di Laspro, uscito a ottobre, abbiamo pubblicato tre interviste, a Cristiano Armati, Christian Raimo e Paola Staccioli, per una questione vecchia ma sempre attuale: la scrittura e l’impegno. Impegno civile, militanza politica, memoria e presente delle lotte. Non questioni accademiche ma argomenti vivi e vitali quando si concretizzano nel lavoro e nella vita concreta di chi ci spende passione, creatività, credibilità. Un argomento che non si chiude qui, ma che apre altre strade, riflessioni e pratiche. Di seguito l’intervista a Paola Staccioli (qui quella a Christian Raimo e quella a Cristiano Armati).
di Luigi Lorusso
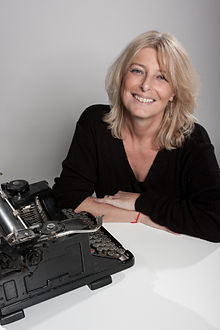 Paola Staccioli, scrittrice e curatrice di diversi libri che raccontano la storia dei movimenti di opposizione in Italia attraverso la narrativa o quella che si può definire storia raccontata, da In ordine pubblico fino a Sebben che siamo donne, è da anni impegnata a creare e rafforzare collegamenti tra il mondo della cultura e quello delle lotte sociali. A lei chiediamo il motivo di questo impegno.
Paola Staccioli, scrittrice e curatrice di diversi libri che raccontano la storia dei movimenti di opposizione in Italia attraverso la narrativa o quella che si può definire storia raccontata, da In ordine pubblico fino a Sebben che siamo donne, è da anni impegnata a creare e rafforzare collegamenti tra il mondo della cultura e quello delle lotte sociali. A lei chiediamo il motivo di questo impegno.
Da diversi anni ti occupi di comporre una “storia del presente”, dei movimenti di opposizione e delle loro lotte, non solo attraverso i documenti storici, ma anche attraverso forme artistiche e letterarie. Perché pensi che la letteratura, il teatro, l’arte aiutino a comporre un quadro di questa storia?
«Giustamente dici “non solo”, nel mio lavoro i due aspetti, quello della storia e quello della narrativa non si escludono ma si rafforzano a vicenda. Io credo che un racconto, uno spettacolo teatrale possano raggiungere un pubblico più vasto rispetto a un documento storico e che arrivino ai sentimenti oltre che alla ragione, con un approccio più diretto e questo permette, forse paradossalmente, di rendere più concreti quei movimenti, quelle lotte che si vogliono raccontare. I due aspetti devono essere collegati: fin dal primo libro che ho curato, In ordine pubblico, ci sono sempre i racconti, ma anche schede storiche che ne spiegano il contesto, dall’ultimo, Sebben che  siamo donne è nato addirittura un sito e un centro di documentazione. La narrativa permette maggiori libertà: può spiegare meglio le motivazioni personali di chi lotta, il contesto umano che può spingere, a volte, anche a infrangere la legge, come spesso avviene nei movimenti di lotta, senza tra l’altro doversi preoccupare di eventuali conseguenze giudiziarie, come dovremmo fare invece in una cronaca realistica».
siamo donne è nato addirittura un sito e un centro di documentazione. La narrativa permette maggiori libertà: può spiegare meglio le motivazioni personali di chi lotta, il contesto umano che può spingere, a volte, anche a infrangere la legge, come spesso avviene nei movimenti di lotta, senza tra l’altro doversi preoccupare di eventuali conseguenze giudiziarie, come dovremmo fare invece in una cronaca realistica».
Hai costituito insieme ad altre persone la fondazione La Rossa Primavera che si occupa della storia della lotta di classe e del presente delle lotte sociali e politiche. Vuoi spiegarci le sue finalità?
«La fondazione nasce per rendere più continuo e collettivo questo lavoro che ho iniziato, insieme ad altri compagni e compagne, da ormai una quindicina d’anni. L’idea c’era già da molto tempo, poi è stata concretizzata adesso anche per una mia situazione personale di malattia (Paola Staccioli ne parla sul blog Le O2 con Serena Ranieri, ndr), che mi ha portato a voler garantire che questo lavoro fatto non si disperdesse. I due campi di attività, la memoria e il presente delle lotte devono marciare insieme, diramandosi poi nei vari aspetti. La fondazione si occupa delle lotte di classe dagli anni ’60, vogliamo occuparci di ciò che è meno rappresentato, meno raccontato e rischia di andare perso. Vogliamo valorizzare la memoria di quella parte della società che si è identificata con i percorsi di trasformazione politica e sociale. Questo tramite un archivio cartaceo, digitale, video che deve raccogliere tutto il materiale, ma deve anche essere qualcosa di attivo, tanto che abbiamo definito il collettivo ArchiviAzione: rendere fruibile il materiale non basta. Vogliamo rendere questa memoria viva, che venga usata anche per il presente delle lotte, che è poi il punto principale: capire il passato serve per comprendere quali sono i punti dell’oggi e del futuro. La fondazione vuole creare anche una rete di solidarietà e di sostegno alle forme di opposizione di classe a cui siamo interni. Uno dei collettivi in cui si articola la fondazione si chiama In Movimento perché vogliamo essere parte delle realtà di lotta che ci sono oggi in Italia. Un altro settore è quello della creazione di una cassa di resistenza, un fondo di solidarietà per i militanti delle lotte sociali che sempre più numerosi vengono colpiti dalla repressione».
C’è un settore della Fondazione chiamato Di pArte – Scritture militanti. Che cosa intendi per scrittura militante? Vedi una narrativa militante oggi in Italia?
«Già la definizione Di pArte rende l’idea di una cultura non ipocritamente neutrale, ma che sia schierata, di parte appunto, che dice chiaramente da che parte sta. Riteniamo che sviluppare oggi le armi della critica con scritture graffianti sia assolutamente necessario: una scrittura che spieghi i conflitti ma che sia anche interna a essi, che guardi al presente delle lotte sociali, alle forme attuali dello sfruttamento, che racconti una condizione che molti stanno vivendo ma che è poco narrata. Vogliamo contribuire alla trasmissione delle lotte di classe dei movimenti e provare a raccontare la storia attuale dal lato degli oppressi, di chi oggi lotta e si ribella.
Esiste quindi quest’arte, questa cultura militante? A freddo verrebbe da dire che non ce n’è molta, ma se solo pensiamo a film come quelli di Ken Loach, al ruolo che ha avuto la musica in questi ultimi decenni, agli spettacoli di teatro civile, hanno supplito a delle mancanze della politica, penso ad esempio a tutto ciò che in ambito artistico è stato correlato a Genova 2001: è stato un contributo militante davvero importante. Per quanto riguarda la scrittura forse c’è stato un po’ di meno. Tutte le volte che come curatrice di libri collettivi su tematiche politiche e sociali ho contattato gli scrittori ho avuto comunque una risposta positiva. Ora stiamo scrivendo un libro di presentazione della fondazione che sarà dedicato al Fuoco: il fuoco come distruzione operata dal capitale ma anche il fuoco come lotta, come risposta, come incendio. C’è una battuta che chiude questo testo che dice: “Abbiamo bisogno di scrittori e di militanti che non abbiano paura di bruciarsi”».
Questo tipo di cultura ha un’influenza reale oggi in Italia? Non rischia di rivolgersi a una cerchia sempre più ristretta di persone?
«Sappiamo tutti che oggi ci troviamo in un periodo difficile per le lotte e i movimenti anche se c’è a mio avviso una ripresa che viene spesso sottovalutata, politica, delle lotte, ma anche culturale, sia pure nella frammentazione. C’è tutta una serie di iniziative interessanti nel prossimo periodo, di culture impegnate, forse anche troppe, un po’ disgregate. Ma non è che non ci sia niente! Parlando di cerchie, la domanda mi fa venire in mente un sasso lanciato in un lago, i cui cerchi poi si allargano. Il fatto di avere poca influenza nella società oggi non è un motivo sufficiente per non fare niente. Se tutta la sinistra di classe non riesce a essere influente nella società, io credo che i sassi nell’acqua vadano comunque gettati per far sì che questi cerchi si allarghino».




 È un piacere parlare di questo tuo viaggio, finalmente. Un viaggio che ci ha colti un po’ tutti di sorpresa. Nel 2015 siamo partite insieme per Kobane ed è proprio in quell’occasione che ci siamo conosciute. Partivamo alla volta di questa città appena liberata. Credo per te sia stata una emozione forte tornarci a distanza di due anni esatti. Ritrovare una Kobane trasformata. Io ne conservo le immagini di distruzione e mi interessa chiederti prima di tutto, come hai ritrovato la città.
È un piacere parlare di questo tuo viaggio, finalmente. Un viaggio che ci ha colti un po’ tutti di sorpresa. Nel 2015 siamo partite insieme per Kobane ed è proprio in quell’occasione che ci siamo conosciute. Partivamo alla volta di questa città appena liberata. Credo per te sia stata una emozione forte tornarci a distanza di due anni esatti. Ritrovare una Kobane trasformata. Io ne conservo le immagini di distruzione e mi interessa chiederti prima di tutto, come hai ritrovato la città. Sebben che siamo donne – Storie di donne rivoluzionarie è un libro uscito nel 2015 per DeriveApprodi, scritto da Paola Staccioli, scrittrice, collaboratrice di Laspro e infaticabile organizzatrice di iniziative culturali, di quella cultura che non esita a definirsi di parte e militante. Il libro, tre anni dopo Non per odio ma per amore – Storie di donne internazionaliste, si concentra questa volta sull’Italia, su dieci donne accomunate dalla militanza politica in organizzazioni rivoluzionarie armate (tranne in un caso) e dalla loro morte violenta collegata a tale militanza. L’arco temporale va dal 1970 al 2009 ma, inevitabilmente, si concentra in particolare sugli anni ’70. Il libro è completato da una esauriente appendice sulle organizzazioni citate nel libro e da una testimonianza di Silvia Baraldini, prigioniera negli Usa e poi in Italia dal 1983 al 2006 per la sua appartenenza a organizzazioni rivoluzionarie.
Sebben che siamo donne – Storie di donne rivoluzionarie è un libro uscito nel 2015 per DeriveApprodi, scritto da Paola Staccioli, scrittrice, collaboratrice di Laspro e infaticabile organizzatrice di iniziative culturali, di quella cultura che non esita a definirsi di parte e militante. Il libro, tre anni dopo Non per odio ma per amore – Storie di donne internazionaliste, si concentra questa volta sull’Italia, su dieci donne accomunate dalla militanza politica in organizzazioni rivoluzionarie armate (tranne in un caso) e dalla loro morte violenta collegata a tale militanza. L’arco temporale va dal 1970 al 2009 ma, inevitabilmente, si concentra in particolare sugli anni ’70. Il libro è completato da una esauriente appendice sulle organizzazioni citate nel libro e da una testimonianza di Silvia Baraldini, prigioniera negli Usa e poi in Italia dal 1983 al 2006 per la sua appartenenza a organizzazioni rivoluzionarie.

 appunto. Nel romanzo, invece, immagino che quest’area venga strappata con la forza ai movimenti di quartiere e si arrivi alla realizzazione di quel progetto di speculazione edilizia ideato nei primi anni ‘90: la costruzione di una città-gioiello, accessibile solo ai ricchi e ai nuovi padroni di Roma. Inoltre, per me questa città è anche simbolo di una crisi generale, sociale ed economica, non solo a livello nazionale ma anche europeo: qui si sono consumati conflitti sociali estremi però sconfitti. Questa Roma distopica è una zattera di pietra (titolo di un capitolo, omaggio all’omonimo libro di José Saramago, nda), che vaga in un mare sconosciuto, trasformata in una Città Stato».
appunto. Nel romanzo, invece, immagino che quest’area venga strappata con la forza ai movimenti di quartiere e si arrivi alla realizzazione di quel progetto di speculazione edilizia ideato nei primi anni ‘90: la costruzione di una città-gioiello, accessibile solo ai ricchi e ai nuovi padroni di Roma. Inoltre, per me questa città è anche simbolo di una crisi generale, sociale ed economica, non solo a livello nazionale ma anche europeo: qui si sono consumati conflitti sociali estremi però sconfitti. Questa Roma distopica è una zattera di pietra (titolo di un capitolo, omaggio all’omonimo libro di José Saramago, nda), che vaga in un mare sconosciuto, trasformata in una Città Stato». «Obiettivo del libro è sempre stato mettere in risalto le contraddizioni che ho visto, e vissuto, all’interno dei movimenti di lotta in generale, con attenzione particolare ai centri sociali. Un fallimento? Forse, sicuramente la mia delusione di fronte a quella volontà di isolamento che li ha resi una sorta di circolo esclusivo, settario, privo di apertura mentale al confronto con realtà alternative. Dinamiche che mi lasciano perplesso e mi hanno allontanato poiché ho assistito alla trasformazione dei movimenti in una sorta di gruppi che agiscono per il mantenimento di una sorta di fittizia supremazia. Pertanto frammentazione e confusione ne sono i prodotti sul piano dell’azione sociale. Questa condizione nel libro l’ho portata alla sua conseguenza estrema: gli individui di fronte alla propria coscienza decidono di battersi fino alla fine. Ma sono consapevoli della doppia sconfitta che stanno subendo».
«Obiettivo del libro è sempre stato mettere in risalto le contraddizioni che ho visto, e vissuto, all’interno dei movimenti di lotta in generale, con attenzione particolare ai centri sociali. Un fallimento? Forse, sicuramente la mia delusione di fronte a quella volontà di isolamento che li ha resi una sorta di circolo esclusivo, settario, privo di apertura mentale al confronto con realtà alternative. Dinamiche che mi lasciano perplesso e mi hanno allontanato poiché ho assistito alla trasformazione dei movimenti in una sorta di gruppi che agiscono per il mantenimento di una sorta di fittizia supremazia. Pertanto frammentazione e confusione ne sono i prodotti sul piano dell’azione sociale. Questa condizione nel libro l’ho portata alla sua conseguenza estrema: gli individui di fronte alla propria coscienza decidono di battersi fino alla fine. Ma sono consapevoli della doppia sconfitta che stanno subendo». pur sempre visionario e pessimista, nel corso della storia acquista consapevolezza di quanto gli accade intorno e prende posizione. Quello, invece, a cui affido la mia speranza è Dago (omaggio a John Fante e al suo romanzo Dago Red, nda), il ragazzo che subisce il tradimento di chi credeva un amico, e le percosse, ma che fa suo un determinato spirito di riscatto. Per quanto riguarda i personaggi negativi, Molise il traditore-infiltrato e Castracane l’ex poliziotto mi sono ispirato al lavoro di Valerio Evangelisti, che proprio nella creazione dei ‘cattivi’ è un maestro. Li rende talmente umani da spiazzare il lettore».
pur sempre visionario e pessimista, nel corso della storia acquista consapevolezza di quanto gli accade intorno e prende posizione. Quello, invece, a cui affido la mia speranza è Dago (omaggio a John Fante e al suo romanzo Dago Red, nda), il ragazzo che subisce il tradimento di chi credeva un amico, e le percosse, ma che fa suo un determinato spirito di riscatto. Per quanto riguarda i personaggi negativi, Molise il traditore-infiltrato e Castracane l’ex poliziotto mi sono ispirato al lavoro di Valerio Evangelisti, che proprio nella creazione dei ‘cattivi’ è un maestro. Li rende talmente umani da spiazzare il lettore».

